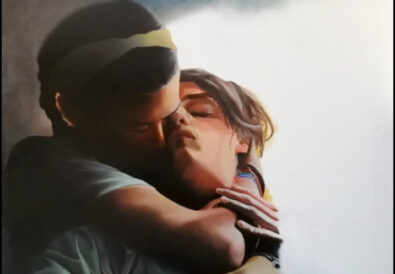Se uno stesso “messaggio” lo scrivo su un quotidiano, lo trasmetto in Tv, lo invio su Twitter, lo “posto” su Facebook o ne parlo a voce è la stessa cosa?
Cosa cambia quando nella comunicazione si modifica il canale che si adopera? Il messaggio non dovrebbe essere sempre lo stesso, così come la fonte e il/la ricevente?
La risposta, semplice e diretta, è “si, cambia”. Cambia perché si modificano il tempo di esposizione (vale a dire, per quanto tempo posso vedere il messaggio e riflettere sul suo contenuto), l’accessibilità (se posso reperire un certo messaggio ) quanto sono attenta/o a quello che leggo/sento, se posso o meno replicare, chi parla/comunica e quale ruolo ha.
La teoria psicologica e sociologica sulla comunicazione si è evoluta molto nel corso degli anni.
Siamo passate/i dall’approccio del “proiettile d’oro”, secondo il quale il messaggio viene inviato e ricevuto allo stesso modo, immodificato, alla teoria del “flusso a due vie della comunicazione”, secondo la quale vi è una co-costruzione del messaggio fra l’inviante e il/la ricevente, fino alle teorie più moderne, come quelle di Petty e Cacioppo o di Chaiken, secondo le quali la comunicazione persuasiva segue due percorsi diversi: se ci sono interesse, attenzione e competenza per l’argomento, allora l’interpretazione avviene cognitivamente (percorso principale), oppure, se la persona è distratta o conosce poco l’argomento, dedicherà minore attenzione al tema e si affiderà all’opinione di una persona più esperta (percorso periferico).
Quello che accade in rete non è virtuale o circoscritto al mondo virtuale, ma interessa la realtà. È importante quindi distinguere fra espressione del proprio pensiero e libertà di comunicazione, che sono cose diverse dalle fake news, dai comportamenti persecutori, dalla diffamazione. La responsabilità delle proprie esternazioni, sia online sia su carta stampata o in TV, deve comunque essere riferita a chi la pronuncia ed essere perseguibile allo stesso modo. La normativa dovrebbe pertanto evolversi in questo senso e una riflessione andrebbe fatta sul fenomeno del “mailbombing” o del “tweetstorming”, ossia, sull’invio di messaggi di uguale contenuto (“messaggi fotocopia”) da parte di più persone verso o contro uno stesso destinatario.
Occorre considerare peraltro anche i vantaggi dei social media, con la nascita di nuove professionalità, ma anche dei rischi derivanti dai comportamenti di chi si nasconde dietro i social e utilizza la copertura dello schermo per sentirsi deresponsabilizzato dal manifestare i propri pensieri anche in modo aggressivo. Sarebbe quindi necessario sviluppare un’“educazione digitale” dei giovani e degli adulti.
Pertanto, il web non è solo uno strumento o un diverso modo di comunicare, ma anche un modo diverso di esprimere le relazioni interpersonali. Si consideri, per esempio, il caso di un giudice che prescrive l’uso di Skype e di Facebook per mantenere i rapporti con i figli/le figlie in caso di separazione o di divorzio dei genitori.
Ma qual è il grado di fiducia che i lettori/le lettrici hanno verso i mass-media? Secondo alcuni/e scarso e in progressiva diminuzione, come dimostra la preferenza verso social media: molti/e preferiscono informarsi attraverso le news online. La grande novità offerta dai mezzi social, infatti, è la possibilità per il pubblico di improvvisarsi giornalisti/e di farsi loro stessi/e promotori/ici di informazione. E questo comporta una serie di vantaggi e di svantaggi. Basti pensare all’affidabilità dei contenuti o alle modalità di diffusione (es. fake news, notizie non verificate o che suscitano allarme sociale). Cambia anche il modo in cui approfondiamo le notizie: leggiamo la notizia sui social media (Twitter e Facebook, per esempio) e poi sfogliamo i giornali. E c’è anche un altro aspetto da considerare: l’algoritmo alla base dei social va a intercettare e a raccogliere informazioni sulle preferenze del lettore/della lettrice. Questo significa che diminuisce la gamma delle informazioni che riceviamo (per es. leggiamo solo quello che ci interessa e i social continuano a riproporcelo), si restringe il numero delle fonti dalle quali riceviamo le informazioni, e queste ultime sono sempre più in accordo con il nostro modo di pensare sicché ci sarà poca diversificazione e possibilità di comparare le diverse posizioni su uno stesso argomento.
La questione dell’algoritmo che “conosce i nostri gusti e li anticipa” è al al centro di un ampio dibattito. Soprattutto con riferimento alla privacy. La responsabilità e il diritto alla privacy. Nel rapporto pubblico/privato, oggi affidiamo molta parte della nostra vita agli operatori privati (anche il controllo di eventuali abusi). Occorre quindi ri-bilanciare questa situazione sollecitando un maggior intervento del settore pubblico, come per esempio l’approvazione del “Codice delle comunicazioni digitali”. Il problema è che l’evoluzione della tecnologia e delle comunicazioni è più rapida di quella normativa.
Inoltre, occorre considerare i “bubbles” (“bolle”), ossia, il numero relativamente ristretto e omogeneo di fonti informative che i lettori/le lettrici utilizzano e di come questo finisca per creare delle “affiliazioni per interessi”, che polarizzano l’attenzione e circoscrivono la quantità e la diversità delle informazioni ricevute. È un po’ un circolo vizioso quello al quale stiamo assistendo attualmente: c’è poca fiducia verso le fonti tradizionali di informazione e si ricorre ai social media e al “giornalismo diffuso”; allo stesso tempo, aumenta la diffidenza verso le fonti non verificate e si cerca conferma nei mezzi di comunicazione tradizionali.
La domanda che sorge è: si tratta di un’evoluzione democratica oppure di un pericoloso strumento di influenzamento delle masse e dei contenuti delle informazioni? Occorrerebbe convergere verso la promozione di un’”educazione digitale” capace di aumentare la competenza a “leggere le notizie” e a distinguere quelle vere da quelle false. Solo così è possibile ripristinare la fiducia dei lettori/delle lettrici.
Ma perché considerare i social media in antitesi ai giornali e alla TV? Vi è piuttosto la necessità di un’interazione che si alimenti reciprocamente. Anche se, al momento, in modo “sleale” perché la TV è regolata da norme precise, mentre i social no. Quello che caratterizza questo rapporto è l’ibridazione dei contenuti e la maggiore attivazione di un consumo individuale con i social. Vale a dire che la fruizione dei social media avviene prevalentemente da parte di una persona singola e isolata da altri/e, ma anche che i contenuti sono più “a misura” degli interessi di ciascuno/a.
Ma dov’è la differenza? La differenza sta nel fatto che la Tv ha il ruolo di mediazione nel raccontare la realtà e quindi svolge una funzione di controllo della qualità dell’informazione, oltre che di spiegazione degli eventi, mentre i social media sono “diretti”.
Ma l’essere “diretti” è anche la finalità che si è posta la televisione, pubblica e privata. Arrivare a tutte/i, parlando a ciascuna/o. Insieme con lo sviluppo della competenza digitale da parte di una platea vasta ed eterogenea (per genere, età, istruzione etc) è quindi importante tenere insieme i diversi pubblici (per es. distribuendo lo stesso contenuto attraverso diversi canali). Per questo è spesso necessario creare una direzione digitale e un team per la gestione dei contenuti. L’asse portante di questa evoluzione è certamente l’“educazione digitale”, che spesso viene accompagnata da una “profilazione” degli utenti/delle utenti, ossia dal tracciamento di una sorta di “identikit” delle preferenze e agendo quindi in piena trasparenza.
In sintesi pertanto sono necessari: il monitoraggio del web, il controllo di qualità sulle informazioni, la centralità dell’“educazione digitale”, la specializzazione e, insieme, l’interazione e l’integrazione fra i diversi canali multimediali.
Tempo fa, l’Economist ha pubblicato un interessante articolo sull’argomento, in cui valuta le opportunità e i rischi (oltre alle modalità per arginarli!), di una corretta ed efficace comunicazione attraverso i social media. Vale la pena leggerlo (https://www.economist.com/news/leaders/21730871-facebook-google-and-twitter-were-supposed-save-politics-good-information-drove-out).